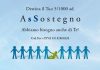Avvocato in Roma, dove esercita nel settore societario, fallimentare e giuslavoristico. Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto dell’economia presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
E’ autore di numerose pubblicazioni nell’ambito del diritto commerciale e del diritto civile.
E’ cultore della materia per la cattedra di Istituzioni di diritto privato presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e di diritto commerciale presso l’Universitas Mercatorum.
QUI IL VIDEO DELL’INTERVENTO – (disponibile dal 15.4.2014)
“Amministrazione di sostegno e disciplina della prescrizione”
Sommario: 1. Prescrizione ed amministrazione di sostegno: le rationes degli istituti; 2. La sospensione della prescrizione nel codice civile; 3. Sospensione della prescrizione e amministrazione di sostegno; 4. Sospensione della prescrizione ed applicazione analogica all’amministrazione di sostegno; 5. Amministrazione di sostegno e scelta dell’istituto per la protezione del soggetto debole; 6. La Corte Costituzionale sull’amministrazione di sostegno; 7. Amministrazione di sostegno ed interruzione della prescrizione; 8. Amministrazione di sostegno e rinuncia alla prescrizione; 9. Il problema della notifica degli atti giudiziari ai soggetti incapaci; 10. Prospettive de iure condendo.
1. Affrontare la questione del rapporto, in termini generali, tra amministrazione di sostegno e prescrizione, significa affrontare il rapporto tra due importanti istituti del diritto civile che si muovono e si sviluppano secondo intenti, prospettive e finalità del tutto diverse e, apparentemente inconciliabili.
Si è ampiamente riferito, e non mi ci soffermo in questo scritto, della natura flessibile dell’amministrazione di sostegno come istituto di protezione delle persone deboli, privo di quei caratteri di rigore e di ristrettezza che invece caratterizzano altri istituti asseritamente di protezione – ma, forse, più di “eliminazione” della persona debole – rispetto all’amministrazione di sostegno. Elasticità, flessibilità, adattabilità al caso concreto, come ben si evince dall’esame della disposizione di cui all’art. 404 c.c. nel rimettere al giudice, in base alla condizione della persona da tutelare, l’estensione, i contenuti e la configurazione dell’amministrazione di sostegno: se maggiormente di tutela, a fronte di una limitata capacità di agire, o di mero supporto, in presenza di un soggetto che conserva ampie e valide capacità di agire e di badare, sostanzialmente, ai propri interessi.
Diametralmente opposta, invece, è la funzione dell’istituto della prescrizione, al quale viene notoriamente assegnata la funzione di garantire la certezza dei rapporti giuridici, riconnettendo all’inerzia del titolare del diritto, dopo un certo periodo di tempo, l’estinzione del diritto, proprio nell’ottica di stabilire un’esigenza di certezza dei rapporti. E’ quindi evidente come gli istituti in parola costituiscano espressioni di diverse funzioni e diversi scopi del diritto e soprattutto assumano diversi contorni per quanto concerne la rigidità della fattispecie che vanno a disegnare: da un lato l’amministrazione di sostegno si presenta dai confini mobili, da adattarsi alla singola debolezza ravvisata; dall’altra, la prescrizione si caratterizza per una serie di elementi che rendono l’istituto di ordine pubblico, tanto da essere, le norme che la regolano, inderogabili.
Già queste sommarie considerazioni possono far comprendere come gli istituti in questione si muovano lungo diverse latitudini e come, di conseguenza, possa risultare complesso coordinare la questione della prescrizione nei confronti di un soggetto che è soggetto ad amministrazione di sostegno.
2. Sul rapporto tra prescrizione e condizione della persona era parzialmente intervenuto il codice del 1942 prevedendo, all’articolo 2942, l’ipotesi della sospensione della prescrizione per la condizione del titolare, nel senso che, secondo il n. 1 della disposizione in esame, la prescrizione rimane sospesa contro i minori emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per i sei mesi successi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità.
Proprio in ragione della regola della prescrizione come disposizione di ordine pubblico, la giurisprudenza di Cassazione è pacificamente allineata nel senso che tutte le norme, contenute nel codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione della prescrizione (come, ad esempio, l’art. 2941 c.c.), integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell’art. 14 c.d. preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati. La tassatività delle previsione di cui sopra trova concreta applicazione nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità per la quale, in applicazione del principio di cui all’art. 2942, n. 1, c.c., il S.C. ha ritenuto di poter affermare la sospensione del decorrere della prescrizione solo nei confronti dei soggetti privi della capacità ad agire, ritenendo, invece, inapplicabile il caso di specie nei confronti del soggetto, come l’inabilitato, parzialmente capace di agire.
3. Verificando in concreto l’applicabilità della disposizione in commento nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, è dato riscontare, a quanto consta, un solo precedente edito, ossia Trib. Roma, 5 settembre 2011. La vicenda alla base della pronuncia in questione può essere riassunta come segue. La madre di una persona che poi sarebbe stata in seguito ammessa all’amministrazione di sostegno, per gravi problemi fisici, aveva sottoscritto una serie di polizze di assicurazione sulla vita, che comportavano la corresponsione di un dato capitale, in base ai versamenti effettuati, alla morte dell’assicurata, in favore della figlia, designata come beneficiaria. La madre, che aveva stipulato questi contratti, decedeva in data 19.10.2007, mentre 13 ottobre l’amministratore di sostegno prestava giuramento e pochi giorni dopo, il 5 novembre 2008, la figlia, alla presenza dell’amministrazione di sostegno, sottoscriveva la richiesta di liquidazione delle polizze. Richiesta che veniva rigettata dalla compagnia assicurativa sul rilievo che trattavasi di polizze dormienti e che quindi, il diritto era prescritto. Ricorreva in giudizio l’amministratore di sostegno, su autorizzazione del giudice tutelare, innanzi al Tribunale, il quale, in accoglimento della sua domanda, dispone l’obbligo, in capo alla compagnia di assicurazione, di procedere alla liquidazione dell’importo delle polizze, sul rilevo che non era maturata la prescrizione, in quanto “dalla nomina dell’amministrazione di sostegno la prescrizione del diritto fatto valore è rimasto sospeso fino al sesto mese successivo alla nomina dell’art. 2942 c.c.”
4. La decisione illustrata, nei termini essenziali e per quanto di interesse in questa sede, pone quindi un principio di significativa importanza che, se può essere accolto favorevole dal punto di vista pratico e della sostanziale equità della decisione, dall’altro pone non pochi problemi di coordinamento con la disciplina generale in tema di prescrizione, come meglio si dirà in seguito. In sostanza, il Tribunale di Roma afferma la possibilità di applicare, in via analogia, al caso di amministrazione di sostegno, l’ipotesi della sospensione della prescrizione di cui all’art. 2942 c.c., che, letteralmente, come visto, prevede la sospensione per i soli casi in cui di diritti relativi a minori non emancipati e interdetti giudiziali – e, quindi, le persone prive della capacità di agire – per il tempo in cui non siano assistite dal rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità. Tale applicazione, a dire del Tribunale di Roma, si giustifica in forza di un’estensione analogica del principio di cui all’art. 2942 c.c., che regolamenta, come visto, ipotesi diverse ma nelle quali il tribunale di Roma ha rinvenuto il medesimo principio applicabile al caso di soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, in un chiaro e – condivisibile – intento di protezione del soggetto medesimo.
Il dubbio che si pone all’interprete, come si vedrà in seguito, è se risulti corretto applicare il meccanismo dell’analogia, previsto dall’art. 2942 c.c. sulla sospensione della prescrizione, originariamente previsto per l’ipotesi di soggetto privi totalmente di capacità di agire, alla diversa ipotesi di soggetto che mantiene la propria capacità di agire, seppur diversamente modalità, nell’ambito dell’amministrazione di sostegno. A ciò sembra di ostacolo il rilievo, sostanzialmente corretto seppur intriso di un certo manierismo ermeneutico, per il quale l’articolo in commento costituisce una norma tassativa, che non consente l’applicazione con modalità secondo il principio dell’analogia, che non sembra sussistere, peraltro, nel caso di specie.
5. L’affermazione, pacifica nella giurisprudenza di legittimità, per la quale la sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2942 c.c. costituisce quanto norma eccezionale, sembrerebbe, quindi, far sostanzialmente propendere per la erroneità della decisione di cui si è fatto cenno, in quanto, come visto, la disposizione in esame trova applicazione per nel caso in cui la condizione delle persone richiamate sia, di fatto,tale da renderli privi di capacità di agire.
Detta impostazione appare meritevole di una riconsiderazione, alla stregua del rilievo, anche sistematico, che l’amministrazione di sostegno ha assunto nel nostro ordinamento. Come infatti correttamente colto dalla Cassazione (Cass. civ., sez. I, 01-03-2010, n. 4866),con l’entrata in vigore della l. 9 gennaio 2004 n. 6, il cui art. 3 ha introdotto nel libro I, titolo XII, c.c., il capo I relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno, l’interdizione è divenuta, nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un provvedimento di portata residuale, occorrendo perseguire, nella individuazione della misura più conforme alle esigenze dell’interessato, l’obiettivo della minore limitazione possibile della sua capacità di agire; in tale contesto è compito del giudice di merito verificare la maggior conformità del provvedimento di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità dell’istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto, non rilevando – quali circostanze atte ad escludere l’applicabilità dell’istituto – l’omissione di una specifica richiesta in tal senso dell’interessato né la mancata indicazione della persona da nominare in qualità di amministratore e dei concreti bisogni che questi dovrebbe aiutare a soddisfare. In altri termini, l’art. 2942 c.c. sulla sospensione delle prescrizione era, all’epoca, pensato e commisurato sull’istituto della interdizione, che rappresentava il (datato ed ormai anacronistico) unico strumento di tutela del soggetto debole. Con l’affermarsi dell’amministrazione di sostegno, la tutela della persona debole si è spostata da un piano di tutela per c.d. “passiva” – il soggetto debole è privo di qualsivoglia capacità, e si affida tutto ad un tutore – ad un piano di tutela “attiva”, nel quale il soggetto debole rimane titolare di diritti da esercitarsi in modo variamente modulato, in base alle esigenze del caso, con l’amministratore di sostegno.
In tale prospettiva, escludere la sospensione della prescrizione in presenza dell’amministrazione significherebbe non applicare l’istituto della sospensione al primo, e più importante – quanto meno, dal punto di vista funzionale e di rispetto del soggetto debole – strumento di tutela del soggetto debole: con pesanti ripercussioni, prima ancora che in punto di equità, in termini di tenuta del sistema.
6. Del resto, proprio la Corte Costituzionale (Corte cost., 09-12-2005, n. 440) ha chiarito e ribadito la piena legittimità del sistema di tutela del soggetto debole come delineato dall’introduzione della amministrazione di sostegno, rigettando la questione di legittimità costituzione degli articoli 404, 405, n. 3, 4, e 409 c.c., sotto il profilo che essi non indicano chiari criteri per distinguere l’amministrazione di sostegno, dai preesistenti istituti dell’interdizione e della inabilitazione – lasciando di fatto all’arbitrio del giudice la scelta dello strumento di «tutela» concretamente applicabile. Tale questione, ad avviso della Consulta, non è fondata, per l’erroneità del presupposto interpretativo, in quanto, la complessa disciplina inserita dalla l. n. 6/2004 nel corpo delle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto, che da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, e dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria; ne discende che in nessun caso i poteri dell’amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore. In altri termini, l’amministrazione di sostegno, de iure condito, è il principale strumento di tutela che il Giudice e l’operatore del diritto devono considerarsi nell’ambito della tutela del soggetto debole; e solo se questi può rivelarsi opportuno, si darà spazio agli altri istituti della interdizione o della inabilitazione.
7. Diverso rispetto al problema finora illustrato è la questione se, invece, possa, il soggetto posto in amministrazione di sostegno, interrompere la prescrizione, direttamente o tramite l’amministratore di sostegno.
Sul punto, la risposta sembra essere positiva, a partire dalla qualificazione dell’atto che va ad interrompere la prescrizione. La giurisprudenza ritiene, ad esempio, che l’atto di costrizione in mora non costituisce un atto negoziale e, quindi, non richiede la capacità di agire (Cass. civ., 07-08-1989, n. 3616). In tal senso, nell’atto di interruzione della prescrizione si verifica una sostanziale dissociazione tra agente e beneficiario, posto che, anche se privo della capacità di agire, l’atto interruttivo potrebbe pervenire dal soggetto che è inquadrato all’interno di uno strumento di tutela o dall’amministratore stesse: profilo irrinunciabile è che, poi, l’atto interruttivo possa portare un beneficio al soggetto nei cui confronti è attuato l’atto.
Solo in tal senso si spiega, ad esempio, l’orientamento della Cassazione per il quale ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l’atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (nella specie, la suprema corte ha ritenuto che l’intimazione a corrispondere le differenze retributive dovute ad un lavoratore, fatta da un rappresentante sindacale che dichiari di agire nell’interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione).(Cass. civ., sez. lav., 09-05-2012, n. 7097).
Sul punto, peraltro, la Cassazione è piuttosto ferma nel ritenere che sia efficace l’interruzione della prescrizione qualora l’atto di costituzione sia indirizzato al rappresentate del debitore, anche se prima non è stato accertato se il difensore possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, dovendo ascriversi siffatta qualità di rappresentante all’avvocato il quale, in nome e per conto del debitore, risponda alla richiesta di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente (Cass. civ., sez. III, 05-12-2011, n. 25984). Orientamento, questo, apparentemente rigido che viene mitigato nel senso che l’art. 2943 c.c., nel prevedere l’efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali, anche se portati a conoscenza del solo procuratore della parte, senza richiedere la ulteriore notificazione personale al debitore medesimo, si riferisce soltanto ad atti tipici e specificamente enumerati, quali l’atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel suo corso, di solito contenuta nella comparsa di riposta o nella fase istruttoria, quando c’è contraddittorio; ne discende che non può essere riconosciuto, ad esempio, effetto interruttivo ad una domanda contenuta in una memoria depositata nel corso di un giudizio arbitrale. (Cass. civ., sez. I, 18-11-2011, n. 24306).
8. Un discorso diverso, invece, concerne il diverso profilo della rinuncia alla prescrizione. Sul punto, come noto, ai sensi dell’art. 2937, 3º comma, c.c., è necessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui; occorre, cioè, che in tale comportamento sia insita l’inequivocabile volontà dello stesso di rinunciare alla prescrizione già maturata; pertanto non configura una rinuncia tacita alla prescrizione il comportamento del debitore che promuove giudizio per la risoluzione del contratto dal quale il diritto trae origine (Cass. civ., sez. II, 22-10-2010, n. 21798).
La rinuncia alla prescrizione presuppone, trattandosi di un attività che va ad incidere negativamente nei confronti del soggetto da cui promana la rinuncia, una piena conoscenza della situazione di fatto e di diritto. La rinuncia alla prescrizione costituisce, pur in assenza di una precisa indicazione giurisprudenziale, un atto negoziale (ma contra Cass. civ., sez. II, 15-06-2009, n. 13870) che, secondo un’autorevole dottrina, prevede, analogamente che gli atti illeciti, la capacità di intendere e volere al momento dell’atto. Da ciò deriva che, nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, per la rinuncia alla prescrizione si ritiene necessaria una specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare contenuta nell’atto di nomina ad amministrazione di sostegno, mentre più discutibile, un punto di validità, sembra essere la rinuncia effettuata dall’amministratore di sostegno o, addirittura, dal soggetto debole tutelato..
9. Il discorso sin qui delineato consente, infine, di affrontare e, come dire, chiudere il cerchio, sotto il profilo processuale, la questione della validità della notifica effettuata nei confronti del soggetto incapace, totalmente o parzialmente. Orbene, che la capacità di agire costituisca elemento essenziale per la ricezione della notifica di un atto giudiziario – con tutte le conseguenze giuridiche del caso – si desume dall’art. 140 c.p.c. , che prevede un particolare meccanismo di notifica dell’atto nel caso, tra l’altro, la persona che si è trovata davanti l’ufficiale giudiziario incaricato della notifica sia, appunto, un incapace.
In realtà, proprio in tema di notificazione di atti giudiziari, la giurisprudenza ha spesso valorizzato – con risultati dubbi in termini di tutela del soggetto debole – le limitate capacità giuridiche del soggetto debole. Se la notifica è esclusa nei confronti dei soggetti – art. 139, secondo comma, c.p.c. – minori di anni 14 o incapaci, – analogamente si è ritenuto obbligatoria la notifica della sentenza che stabilisce l’interdizione nei confronti dell’interdetto (app. Milano, 15.7.2003), ritenendolo parte del giudizio in questione. Oppure si è ritenuto che l’assenso fornito dal curatore di un soggetto inabilitato all’impugnazione della sentenza esaurisce l’attività demandata all’organo di protezione dell’incapace, che, nel manifestare la propria volontà, si rende parte di un atto unilaterale complesso «a complessità disuguale», con la conseguenza che la sostanziale unicità dell’atto e la incontestata elezione di domicilio compiuta dal ricorrente in cassazione presso il proprio difensore nel giudizio di legittimità rendono del tutto valida ed efficace la notifica del controricorso effettuata in detto domicilio senza necessità della sua notificazione anche presso il curatore (Cass. civ., sez. III, 25-07-2006, n. 16937)
10. Le considerazioni illustrate in precedenza su due tematiche – quella della prescrizione e quella notifica degli atti giudiziari – nei confronti di soggetti, in termini generali, con limitate capacità di agire, ci confermano come, da un lato, l’introduzione dell’amministrazione abbia radicalmente modificato l’approccio degli operatori alle problematiche relative alla tutela dei soggetti deboli; e, dall’altro, che l’ordinamento nel suo complesso deve, ancora, pienamente recepire tale novità, essendo, prima ancora giuridica, una rivoluzione culturale. In tal senso, si auspica, dal parte del legislatore, un intervento su alcuni dei profili in precedenza illustrati, nel senso adattare, tramite opportuni richiami ed integrazioni, un tessuto normativo che si non considerava, naturalmente, l’istituto dell’amministrazione di sostegno e che, quindi, si trova costretto, in termini talvolta contraddittori, a fronteggiare diverse esigenze.
La bussola sarebbe indubbiamente quella di garantire, anche nella gestione del tema della prescrizione e della notifica degli atti giudiziari, ampia tutela in favore del soggetto debole; ma senza dimenticare che lo stesso è, come noto, titolare di diritti e che l’amministratore di sostegno deve solo, nei limiti imposti dal giudice, valorizzare, integrare e coadiuvare la volontà del soggetto debole per poterla pienamente renderla efficace.