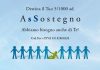Medico chirurgo specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni, dipendente della ASS n.1 Triestina, presta attualmente il proprio servizio presso la Struttura Complessa Accertamenti Clinici di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione quale responsabile della S.S. Deontologia e Responsabilità Professionale occupandosi in prevalenza dell’espletamento delle prestazioni medico legali aziendali attinenti alle richieste di risarcimento da malpractice sanitarIa.
QUI IL VIDEO DELL’INTERVENTO – (disponibile dal 15.4.2014)
Amministratore di sostegno e trattamenti sanitari, da risorsa per la persona a paradigma della medicina difensiva ?
Secondo il Rapporto Osservasalute aree metropolitane 2010, a Trieste spetta il primato di città più anziana d’Italia con una età media della popolazione oggi di poco superiore ai 47 anni.
In una società in evidente e progressivo invecchiamento si rende così necessario sempre più frequentemente sottoporre a trattamenti chirurgici o ad accertamenti diagnostici invasivi soggetti in condizione di incapacità naturale non ancora o non già sottoposti a tutela né beneficiari di amministratore di sostegno ed al tempo stesso non in grado di esprimere un valido consenso (o, più spesso, dissenso) a quanto proposto.
Il problema, non nuovo, appare a tutt’oggi sostanzialmente ancora irrisolto malgrado più interventi di natura giuridica e metagiuridica volti a disciplinare soggetti e procedure.
A riguardo possiamo qui ricordare la Convenzione di Oviedo, ratificata con legge n. 145 del 2001 che agli artt. 5, 9 e 21, in riferimento a un trattamento medico, impone di tenere conto della volontà del paziente non in grado di esprimersi o, ancora, l’art. 38 del vigente Codice di Deontologia medica 2006 che recita testualmente “Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.
Interessante è anche richiamare una pronuncia risalente del Giudice Tutelare di Palermo (Decreto del Tribunale di Palermo del 19/12/2000) che 14 anni or sono, interpellato in ordine a chi dovesse esprimere il consenso al trattamento sanitario per un soggetto non in grado di autodeterminarsi in una scelta consapevole così si era espresso: “… Vista la richiesta del 18.12.2000 del dott. XY medico di reparto della Casa di Cura XY relativa all’autorizzazione ad effettuare l’intervento chirurgico di sostituzione protesica dell’anca dx di XY … affetto da Demenza Senile … nell’ipotesi in cui il soggetto non ha la capacità di intendere e volere il c.d. consenso informato non può essere delegato a terzi, Tutori o Curatore nominati dal Giudice Tutelare, atteso che si tratta di un atto di natura personale … considerato che in tali ipotesi il medico ha il compito di stabilire in via autonoma l’opportunità di eseguire un determinato intervento, con la conseguente responsabilità di carattere professionale … il consenso informato non è previsto nelle norme contenute nel codice civile, relative alla tutela degli interdetti ed alla curatela degli inabilitati, norme che possono per analogia essere applicate nelle ipotesi di curatela provvisoria; P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere”.
Quattordici anni or sono il problema sembrava affrontato e già risolto con la proposizione che tale compito (esprimere il consenso) non gravava in capo ai familiari privi di titolo alcuno per esprimere un consenso o un dissenso e men che meno al Giudice Tutelare: solo il medico era considerato in possesso delle conoscenze utili per poter porre in essere l’intervento opportuno sicchè questi – e solo lui – doveva valutare nell’ottica della rapporto rischi beneficio se procedere o meno nell’esclusivo interesse delle persone assistita assumendosi altresì la piena responsabilità delle cure come attuate.
Non desta peraltro sorpresa l’osservare che non infrequentemente, oggi come allora, nel momento in cui si versi in contesti di criticità nella gestione del paziente non in grado di autodeterminarsi, viene ricercato un contatto con gli organi giudiziari al fine di individuare per quanto possibile insieme una soluzione al problema e ciò è ancora più vero in determinate fattispecie.
Da tempo, tuttavia, il ricorso all’autorità giudiziaria nel tentativo di ottenere una autorizzazione a procedere è stato (talora duramente) stigmatizzato.
Per restare in ambito locale, il Tribunale di Pordenone, l’11 gennaio 2002 aveva ritenuto che i medici che avevano “interpellato una entità esterna ovvero la Procura della Repubblica sia pure del tutto rispettabile e del tutto autorevole” erano caduti in errore “dimostrandosi (in ciò) una mancanza di responsabilità e di capacità di rispettare di per sé la persona come tale”.
Qui la problematica in questione era relativa a una trasfusione di sangue da praticare su un soggetto al momento non capace.
In epoca più recente, a far tempo dal 2004, l’introduzione nell’ordinamento giuridico della nuova figura dell’amministratore di sostegno, definibile per certi versi come epocale nella continua evoluzione della tutela degli interessi della persona, per la specifica problematica oggi in discussione si è talora venuto a proporre come fattore confondente.
Immediatamente recepito l’inedito soggetto giuridico dal Codice di Deontologia medica del 2006, in ambito sanitario la funzione dell’amministratore di sostegno è stata nel tempo variamente interpretata fino al punto di essere non di rado individuato – laddove in questione gli interessi dell’incapace naturale – come ineludibile soggetto di riferimento per integrare con la sottoscrizione del consenso la prestazione sanitaria, di qualunque tipo essa fosse, dall’intervento chirurgico ampiamente demolitivo al mero accertamento strumentale con mezzo di constrasto.
La doverosa critica alla (più forzosa che voluta ?) distorsione nell’interpretare in ambito sanitario ruolo e competenze dell’amministratore di sostegno va comunque temperata avuto riguardo del difficile contesto storico in cui debbono operare le professioni sanitarie, a meno che non si voglia ignorare o scotomizzare i profondi cambiamenti intervenuti nel rapporto con le persone assistite negli ultimi trent’anni.
Ipermedicalizzazione della società, recessione economica, crescente sfiducia nei confronti del personale sanitario anche sulla scorta di campagne mediatiche votate alla spettacolarizzazione del fatto e non già alla piena comprensione dell’evento, aumento della scolarizzazione in uno con una giurisprudenza sempre più attenta e severa nel giudicare l’operato dei medici, sono i determinanti che a lato del disgregarsi del rapporto fiduciario paziente/medico hanno generato nuovi schemi operativi plasmati su regole non scritte oramai ampiamente note e descritte a presunta (?) salvaguardia dell’attività professionale.
Ecco quindi la progressiva deviazione da buone pratiche e condotte abituali traducentisi per lo più in richieste di accertamenti strumentali, di laboratorio nonché specialistici, esuberanti rispetto alle reali necessità, all’introduzione in terapia di farmaci non indispensabili, fino ad evitare i casi più complessi al fine di scongiurare accuse di malpractice: si è creato, in sostanza, un sottosistema clinico grandemente diffuso nei paesi più evoluti definibile come “medicina difensiva”.
Per dare l’idea di quanto il fenomeno sia diffuso, nel 2010 uno studio curato dal Centro Studi Federico Stella sulla Giustizia Penale e la politica criminale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha evidenziato come dei medici intervistati il 90,5% abbia riconosciuto di aver adottato almeno un comportamento di medicina difensiva durante l’ultimo mese di lavoro.
In questo contesto si inscrive allora perfettamente la ricerca di un generalizzato ricorso all’amministrazione di sostegno – che alla luce di quanto precede potrebbe essere quanto meno opinabile definire del tutto improprio – pur nella consapevolezza che si tratterà di un soggetto che andrà a esprimere un consenso ad un trattamento di cui talora poco o nulla conosce o poco o nulla comprende.
Questo poco importa: sarà comunque assolto compiutamente l’adempimento burocratico come tale interpretato e come tale vissuto anche sulla scorta di quanto detto sopra.
Del resto, la presenza “latente” dell’autorità giudiziaria nelle attività sanitarie viene fortemente sentita nel vissuto clinico quotidiano spiegando un inevitabile effetto negativo amplificato dalla percezione di una carenza di indicazioni operative rilevanti da parte degli Organismi rappresentativi.
Si assiste, inoltre, ad una parcellizzazione di indicazioni e suggerimenti provenienti da Ordini e Società scientifiche non sempre di segno univoco.
È sconsolante osservare che la produzione legislativa negli anni, lungi dall’intervenire in senso propositivo – anche e soprattutto in conseguenza delle indicazioni provenienti dall’interno della categoria – non solo non ha introdotto elementi innovativi che tenessero conto del reale contesto in cui l’attività viene a svolgersi ma non si è neppure interessata di aggiornare efficacemente quanto già esistente.
Nel “vuoto legislativo” odierno si è così assistito al sostituirsi di soggetti estranei al contesto sanitario nell’introduzione di canoni di condotta.
Non è chi non veda che le sentenze, in particolare quelle della Corte Costituzionale e di Cassazione, sono progressivamente e sempre più divenute l’elemento su cui plasmare le procedure acquisendo un ruolo disciplinante e vincolante quanto – se non più – di quello legislativo: se questo è vero, lo è in particolar modo per quanto riguarda le modalità di espressione del consenso informato.
Oggi modalità e tempi dell’informazione divengono conoscenza-patrimonio del professionista quasi in diretta ed esclusiva conseguenza dell’interpretazione-applicazione giuridica di proposizioni precettive riformate attraverso strumenti propri ed esclusivi della tecnica giuridica.
Ci si deve quindi interrogare se non sia giunto il momento per proporre dall’interno delle categorie sanitarie opzioni normative che dimensionino tale ambito o se sia invece preferibile assistere passivamente all’ulteriore lievitare della creazione giurisprudenziale.
Ad ogni modo, assenza di specifici riferimenti di carattere legislativo, indeterminatezza delle previsioni di natura deontologica e rigidità di articoli di legge pensati per altri contesti e in altre epoche storiche sono i fattori che hanno indotto sanitari sempre più preoccupati per le possibili conseguenze legali della propria attività a percorrere strade parallele alla piena e esclusiva assunzione di responsabilità per assicurare la (solo formale) legittimazione del trattamento posto in essere.
Né pare soccorrere l’art. 54 del codice penale posto che l’aggettivo “attuale“, che lo caratterizza, per come interpretato lo rende di fatto inapplicabile nella più parte delle circostanze qui di interesse.
Diverso sarebbe l’assumere che lo stato di necessità può prospettarsi – sotto il profilo temporale – ben prima del subentrare di una urgenza o emergenza clinica nella prospettiva globale di cura della persona secondo la miglior scienza ed esperienza.
Ad oggi, inoltre, il Codice di Deontologia Medica nella sua attuale formulazione sembra porsi in apparente contrasto con le intervenute novità legislative nel momento in cui non prevede affatto di dover acquisire il consenso per il tramite dell’amministratore, valorizzando invece la figura in via di (auspicata) dismissione del tutore.
Recita infatti testualmente l’odierno Codice (dicembre 2006, oggi in via di riforma) all’Art. 37, Consenso del legale rappresentante: “… allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l’autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell’incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili”.
È proprio in quei casi nei quali vi è la possibilità di dilazionare il trattamento, definibili come urgenti ma nei quali viene esclusa la necessità dell’intervento cogente, che la questione su delineata si appalesa in tutta la sua problematicità.
Non può qui non ricordarsi quanto ribadito in epoca non recente dalla Cassazione penale circa il diritto all’autodeterminazione paziente: lo stesso viene meno “solo nel caso di trattamenti obbligatori ex lege, ovvero nel caso in cui il paziente non sia in condizione di prestare il proprio consenso o si rifiuti di prestarlo e d’altra parte, l’intervento medico risulti urgente ed indifferibile al fine di salvarlo dalla morte o da un grave pregiudizio alla salute … La mancanza del consenso (opportunamente “informato”) del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina l’arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e la sua rilevanza penale” (Cass. pen. sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572).
Intervenire su un assistito con un quadro clinico richiedente una operazione o un accertamento invasivo definibile come urgente ma differibile in assenza di consenso, pur ponendo in essere esattamente quanto verrebbe attuato su un soggetto di pari età e con pari patologia ma in grado di esprimere un consenso “valido” (ovvero fare ciò che chiunque altro farebbe nel medesimo modo nella stessa circostanza), potrebbe dunque esporre a conseguenze del tutto imprevedibili in ambito giudiziario.
È questa la motivazione che porta a realizzare percorsi clinicamente incongrui nei quali si attende la nomina (questa sì, con carattere di urgenza !) di un amministratore di sostegno cui somministrare e far sottoscrivere un modello informativo nonché uno di adesione al trattamento proposto, talora a discapito del vero interesse della persona assistito (che sarebbe quello di essere trattato entro un arco temporale ristretto) in relazione all’allungarsi dei tempi amministrativi necessari per completare il percorso.
Ma si è sempre così certi della volontà di impegnarsi da parte del soggetto nominato?
O non si dovrebbe prendere atto di quanto accade realmente nella quotidianità, posto che ritmi e tempi dell’agire concedono a soggetti che restano comunque “estranei” assai poco spazio per quell’indispensabile approfondimento che sottende il manifestare una volontà in positivo o in negativo?
Piace invece immaginare il ricorso all’amministrazione di sostegno non già per ottenerne un consenso sterile e privo di significato (… una firma su un pezzo di carta) ma per verificare in via a questo preliminare i valori della persona in relazione a quanto proposto/ipotizzato in contesti di effettiva eccezionalità del trattamento da attuare, dove risulti imprescindibile la piena conoscenza da parte dell’amministratore del vissuto della persona, delle sue aspettative e dei suoi convincimenti.
Un rinnovato ripensamento sul ruolo dei familiari o delle persone d’affetto nell’ottica di una loro piena inclusione nel percorso di cura (e quindi anche nella formazione del consenso) che non debba necessariamente transitare per le aule di un Tribunale nonché per la valorizzazione della documentazione sanitaria quale indispensabile supporto per la riproducibilità delle motivazioni che hanno determinato l’agito (o il non agito) sarebbe senz’altro attuale.
Per quanto possa apparire singolare, oggi, l’importanza della figura dell’amministratore di sostegno in ambito sanitario appare sempre più irrinunciabile in circostanze di segno esattamente opposto a quelle per le quali si pensa con più frequenza che a questi si debba ricorrere. soggetto
Ci si riferisce qui espressamente alla manifestazione del dissenso alle cure laddove la persona a un certo punto del suo percorso non sarà più in grado di esprimerlo: disporre di una figura a questo deputata si propone oggi come condizione ineludibile per poter assicurare un pieno rispetto della dignità della persona umana.
Fino a quando per il tratto finale della vita non saranno stabilite regole certe l’amministratore di sostegno continuerà ad essere vissuto in ambito sanitario, ma non solo come unico punto di riferimento e questo non già per l’autorizzare il fare ma per imporre l’astensione, il non fare.
Conclusivamente preso atto che il punto nodale continua ad essere la condizione di “vuoto legislativo” in relazione alla potestà decisionale del medico nel caso in cui l’incapace naturale debba essere sottoposto ad un trattamento sanitario privo di quel carattere d’urgenza indifferibile che non consenta di invocare lo stato di necessità, l’esperienza del periodo più recente mostra come non sia percorribile la strada della nomina di un amministratore di sostegno estesa ad ogni caso, impropria se immaginata come regola:
La fattispecie andrebbe comunque disciplinata diversamente con l’indispensabile e condiviso supporto della Magistratura e non già con la “rincorsa all’ultima sentenza”, quanto meno nelle more di provvedimenti legislativi che appare difficile immaginare possano intervenire a breve.
Questo ove non si volesse aderire all’opinione secondo cui le condotte in tali situazioni potrebbero (o dovrebbero ?) essere modellate sulle specifiche previsioni del codice di deontologia medica del 2006 (decisione in scienza e coscienza) che, pur se fonte metagiuridica, rappresenta ancora l’attuale unico riferimento in proposito, riservando il ricorso all’AdS a casi del tutto peculiari quali, ad esempio, il dissenso della persona al trattamento manifestato in epoca precedente alla perdita della capacità decisionale o l’eventuale dissenso di uno dei soggetti nel contesto parentale di supporto.